Non ho nemmeno la forza di fare filone, è scivolata via dalle dita e dalla gola.
Guardo questa città di mare che condivide con le altre l’odore, di salsedine e lacrime.
Le case, gli edifici accatastati come a voler rubare un pezzo di mare e di sole. Pezzi dimenticati di un meccano rotto e arrugginito.
Rotolando verso sud.
Coppa della Divisione.
Raccontare di “calcetto” giocato senza essere “carina, carina” e non è facile, senza le luci rosse ma con le luci e basta, quelle della ribalta.
Un milione di buone ragioni per non partire, non le solite, diverse, sensate. Cosa ci facciamo qui, davvero?
Se non importa a loro, alle giocatrici, alle attrici di questo spettacolo, perché dovrebbe importare a me, ad altri.
Io racconto per professione questo sport e mia madre non ha mai visto nemmeno una partita, non mi chiede nemmeno che cosa accade. Non le importa nulla.
Arriviamo a destinazione con il sole negli occhi, con l’acqua sulla destra e il cuore a sinistra.

Le case antiche, incollate dai ricordi, l’odore dei nonni, di crostata e di riflessi stanchi, di piastrelle strane, mattonelle disegnate a rombo.
Le parole nascoste dietro alla musica “indie” per quella necessità di sentirsi unici, nella speranza che parole e musica rendano la parola “diverso” splendente come il sole.
Cinque ore dopo e 486 chilometri più in là, ci sono ancora i peti vocali di quelli disposti a credere a una menzogna piuttosto che fare i conti con la verità. Troppo stupidi o troppo corrotti, oppure le due cose insieme.
Ancora una volta a sporcare di bugie lo sport, quello che praticano queste donne, sono gli uomini che lo gestiscono anche se non le capiscono mai davvero. Capaci di farlo tornare calcetto con una telefonata ben piazzata.
Quello che non mi parla e ha quest’aria seria di chi è ancora vivo al proprio funerale e finge di non vedermi, per passare con il rosso, per una storia vecchia di anni che aleggia nello spazio arioso tra le sue orecchie. La giornata è ancora lunghissima.
Rivoglio il palazzetto di Chiaravalle con la fibra, le sedie di metallo e gli spalti attaccati al campo, fa freddo eppure siamo così a sud.
In campo si gioca a tennis alla prima, si gioca ad uno sport bellissimo nella seconda. Una partita che quelli che scrivono bene definirebbero: “spot per questo movimento”.
A guardarla sugli spalti frotte di genitori, venuti a riprendere le loro bimbe che danzano nell’intervallo.

Cosa ci rende diversi, unici?
Perché qualcuno dovrebbe leggere o anche semplicemente guardare queste righe, quelle foto, per una ragione diversa dall’onanismo digitale?
Una vecchia reflex, pezzi di diapositive, 24 scatti in bianco e nero e quella voce che somiglia tanto alla mia sconsolata afferma: “non scattare, per quello ci sono le cartoline”.
Le Carrè, La Talpa.
Quel volume piegato sullo scaffale vicino a Garcia Lorca, la rosa rossa schiacciata tra le pagine, le foglie vecchie di 40 anni o forse più. Un diario, una guerra e anche più d’una, perché lui è capace di comprendere che una foto deve possedere la capacità di raccontare, senza essere uguale a milioni di altre, identiche a se stesse. Un soldato con le mostrine e senza ph/photografer/photographer/fotografer cattura questo semplice afflato d’arte e le racchiude in quelle semplici parole.
Un insegnamento fondamentale: “non scattare, racconta”. C’era anche una percentuale di parsimonia nascoste tra le lettere, in stile Scrooge da parte sua, ne sono sicuro, 24 scatti in bianco nero da sviluppare costavano tanto, 24 diapositive avevano il valore equivalente di un rene al mercato nero.
Non puoi sprecare uno scatto.
Da cuore al dito, il tratto è breve, dallo scatto al ricordo c’è invece un mare di sensibilità che non tutti riescono a navigare.

Il lungomare, gente a passeggio, qualcuno che ti chiede una sigaretta e quel brusio della domenica mattina, non c’è niente di nuovo. Niente volti, niente storie. Eppure dal quel porto sono passati le divinità dei greci, l’olio e l’olivo, il teatro e la filosofia.
Bimbi vestiti a festa per carnevale, quelli che sono vestiti tutto l’anno, quelli che aspettano il mercoledì grasso e quelli che grasso basta e avanza.
Il solito racconto, ritrito e consumato all’inverosimile, quell’odore di stantio. Come quel vestito che hai indossato una volta di troppo, anche se l’hai scelto anche oggi nel giorno della festa, resta liso e mostrerà i segni del tempo, nelle pieghe dei tuoi movimenti.

Menzione inevitabile per la “photographer” con l’abilità di arrivare dal nulla e mettersi davanti all’obiettivo di altri senza nemmeno scusarsi. Ogni volta che accade e accade puntualmente, rimpiango la “casella” giusta, quella dove s’è fermata perfino l’amicizia di “Pluto” Aldair. Siamo un po’ tutti più soli quando non c’è la figura minuta di chi scattava già quando le fotografie si facevano stampare e raccontavano lo sport.
Sono sicuro che quelle foto scattate impedendo la visuale ad altri siano destinate al Pulitzer o forse alle pulizie, decisamente più la seconda che ho scritto.
Quante volte in questi due giorni mi sono sentito ripetere: “chi te lo fa fare?”. Suonava più come “trovati un lavoro serio”, che poi in realtà non ne ho mai fatto uno davvero serio, perché lavorare in editoria, lavorare con le parole non era considerato “serio” nemmeno dei miei, affrancati dal ricordarmelo dall’esistenza di un contratto a tempo indeterminato.
Tu che rubacchi una foto, un video solo per metterlo sul tuo profilo social, sappi che quella foto e quel video sono costati denaro, della reflex, del viaggio, del soggiorno, per venire a vedere te che poi non curante t’appropri del lavoro di altri ma chiedi che qualcuno racconti che non pagano il tuo di lavoro.
Applauso alla tua coerenza.

Vero, chi ci fa fare 1000 chilometri in due giorni, andare a dormire alle 5 del mattino per scrivere una storia su di uno sport che perfino i suoi attori trattano senza rispetto.
Non ha senso cercare idee nuove, provare a raccontarvi per farvi diventare grandi, forse ha ragione quel settantacinque per cento che vi tratta come un “servizio da matrimonio”.
Siti illeggibili, le dirette con il telefonico, “quanto stanno”, “quanto manca”, “basta che si vede”.
Bau, Bora Bora, le “chempionz”, dormire sul divano, il figlio del presidente che stampa le maglie e parla di scommesse, le marchette anche quelle telefoniche, gli impicci, la musica classica e i jingle.
“Chi te lo fa fare?”
Nessuno, l’ho trovata la risposta, tornando verso nord. La notte appiattisce tutto. Rimuove lo sfondo e mi lascia con l’essenziale. Bisogna amare, la stessa musica, condividerla ma se quella che ascolto è una musica diversa allora devo seguirla.
Non è colpa di nessuno, non ci sono colpe.
Si fermano qui le parole, forse solo per riposare un po’, forse per cercare una strada diversa da questa.

Tempo di Finale
Comparire per poi scomparire, il portiere e non è quello di notte, l’albergo e il pallone che s’infila sotto il sette. Le gambe che non seguono la testa, la testa che ti dice qualcosa che il tuo cuore non vuole ascoltare. Occhiali e baffi finti, il cappellino calato sulla testa e da qui vedo tutto.
Vinci la Coppa ma non sei campione di Italia, quello accade quando vinci lo “Scudetto”.
Come in un Football Manager, come gli occhi smarriti di chi ti chiede una soluzione perché non riesce a trovarla da sola, una qualsiasi soluzione. Ti tende una mano perché tu possa aiutarla ad uscire dal pantano, ma non riesci a trovarla. Le stringi forte quella mano ma lei continua a scivolare, suda, si affanna ma scivola giù insieme ai numeri di quel cronometro che corre troppo forte.
Oggi conta vincere, non importa il perché ma solo il come.
Ho sempre avuto paura delle finali, perché sono per sempre, non puoi rimediare e non puoi ripararle, resteranno così, buona la prima.
Restano i coriandoli che s’impastano con le lacrime secche.
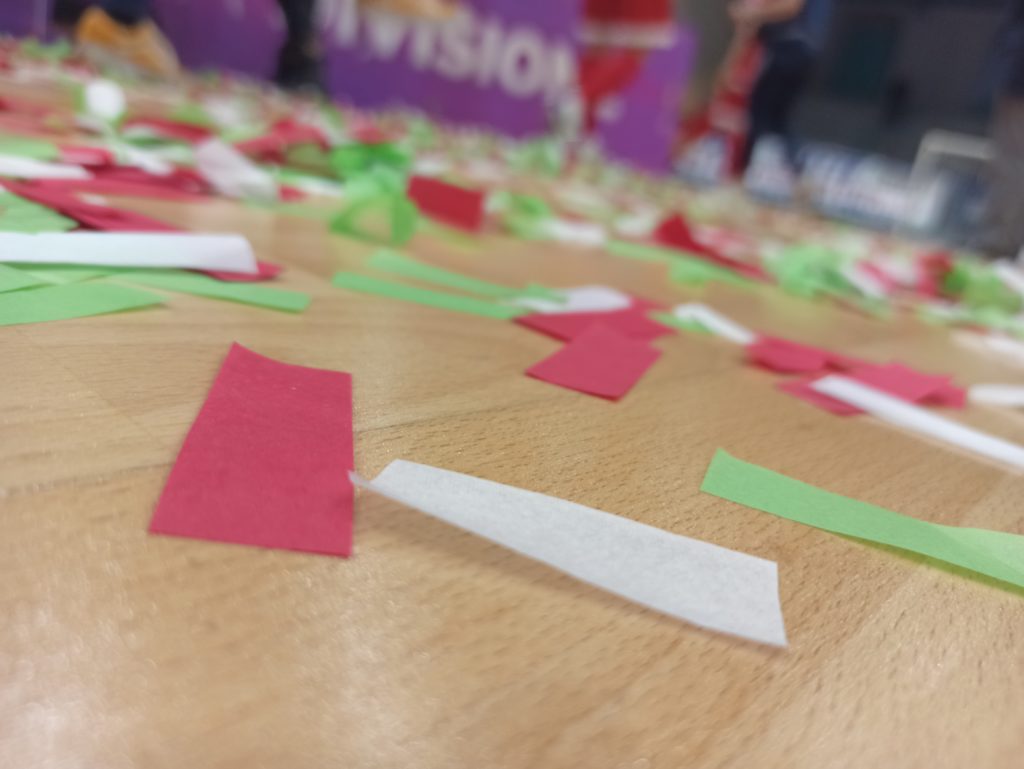
Finisco sempre seduto dalla parte sbagliata, con quelli che hanno perso, forse perché lì c’è sempre più spazio e trovo facilmente un posto.
“Guarda Papà quanto è forte quel giocatore lì”, come fanno i bimbi con i papà, tirandoli per il lembo della maglia ma al mio del calcio è sempre importato poco del calcio, anche se l’ha giocato.
Non sono tutti qui i miei giocatori preferiti, che poi sono tutte atlete nate con i piedi giusti ma il sesso sbagliato, fossero state uomini ora vedrebbero palcoscenici pieni di lustrini e riflettori.
Sono tutte occhi e cuore, uno spettacolo inaspettato di sorrisi e sguardi, hanno il profumo delle parole importanti perché dette con quel poco di fiato che resta, sussurrate quasi.
Venite più vicino se volete ascoltare.
Click, Clack.
Ci fermiamo a fare metano, a chi tocca pagare? L’autostrada, il pedaggio. Mangiamo? Preferisco dormire, siamo a casa. Miao, il gatto bianco e sono troppo stanco per dormire, prendo gli appunti e continuo a scrivere.







